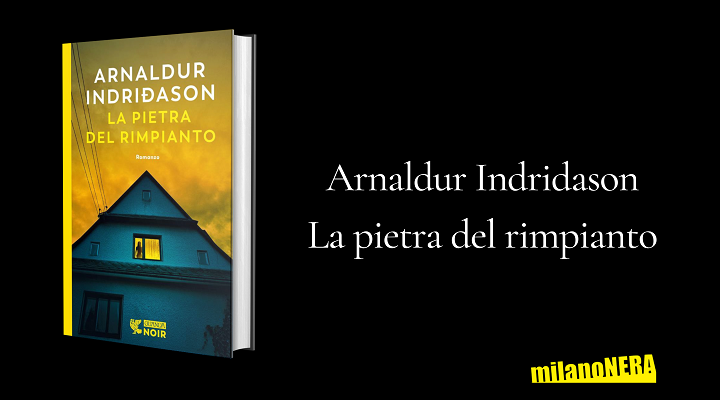L’Islanda esiste per davvero e forse il freddo non è nemmeno l’elemento principale! Arnaldur Indridason ci prende per mano e non ci abbandona quando a Reykjavik, capitale dell’isola ai bordi del Circolo Polare Artico, la placida quotidianità di un quartiere borghese è squarciata dal ringhio di alcune pattuglie a sirene spiegate. Una donna è stata trovata morta in casa, forse soffocata con un sacchetto di plastica. I primi controlli degli investigatori individuano un biglietto e riconoscono il numero segnato: è quello dell’ex detective Konráð, ormai in pensione.
Egli racconta che tempo prima la signora Valborg, un’anziana gravemente malata, ne aveva invocato l’aiuto per ritrovare il figlio, dato in adozione molti anni prima, di cui non sapeva nemmeno se fosse maschio o femmina, ma lui non accettò. Oppresso dai sensi di colpa, tempo dopo, l’ex detective si mette alla ricerca come un segugio di quel bambino adottato e scomparso. Questo primo percorso narrativo ne interseca un secondo, peraltro già affrontato nei romanzi precedenti, e riguarda l’assassinio, rimasto impunito, del padre di Konráð davanti alla Cooperativa di macellazione.
Qui mi fermo, allacciamo le cinture e prepariamoci al decollo: una verticale di tensione tagliente e di verità abrasive.
Una gemma pura questo romanzo di Indridason, che prende spunto da una vecchia leggenda che vuole un’aquila volare basso su una madre in cammino per rubarle il figlioletto che teneva in braccio.
Non ha cali di tensione ma un climax secco e senza scampo, un crescendo sinuoso e impetuoso, deciso e senza inciampi: un viaggio nel dolore, come correttamente è stato definito, che non offre via d’uscita nè consolazione, ciononostante un viaggio da intraprendere per capire fino a che punto siamo capaci di arrivare senza voltarci. E per vivere la consapevolezza che da certi viaggi non si torna; e non sempre tutto ciò è un male!