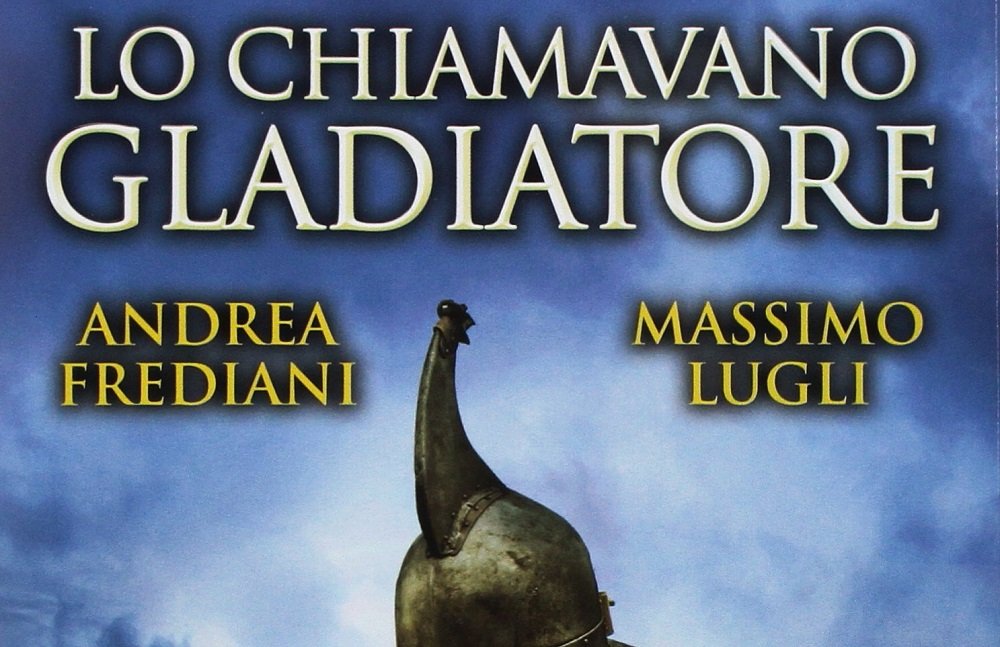La cornice storica che dal colpo di stato dei primi anni Cinquanta in Iran conduce a quadri femminili privati del riconoscimento identitario, fa del romanzo di Parsipur non soltanto la premessa alla pellicola omonima – cui è valso il Leone dArgento alla regista e video artista iraniana Shirin Neshat – ma lopportunità di risanare in prosa visiva ferite e cattività epocali.
La struttura per episodi dietro cui il lettore osserva e partecipa, secondo la regola primaria del vissuto riconoscibile o, allopposto, del rifiuto di ciò che per epoche e genere potrebbe cascargli addosso come alieno, predispone alla conciliazione simbolica in cui le storie trovano sfogo in un rifugio comune.
Lalbero della verginità di Mahdokht, che decide di piantarsi a terra perché solo ciò che è puro dia frutto, getta radici là dove il ritrovo delle donne senza giudizio è miracolo surreale e rinascita. Farrokhlaqa, dopo la permanenza infelice accanto a un marito ignaro, ritrova nello stesso giardino a Karaj il talento di una scrittura prima disabitata. Come quello islamico, festa dellozio e della pacificazione interiore, il cerchio verde di questo Eden è nutrimento per sola voce femminile.
Sa accogliere una come Faizeh, sposa mancata e colpevole di aver iniettato sangue negli occhi di Amir per limpurità sospetta della sorella Munes, punita con la morte; fa risvegliare questultima come interprete del pensiero e accetta la pelle segnata della prostituta Zarrinkolah ossessionata da uomini senza volto.
La rivoluzione è allora di un gruppo di combattenti al riparo dellimmaginifico, comerano gli sfondi letterari per le allieve di Azar Nafisi in Leggere Lolita a Teheran e come qui si trascina in fuga dalluniverso maschile che tutto opprime.
La sensualità mummificata da silenzi indotti, dallignoranza beffata dai dogmi che fanno continuamente incespicare il piacere fino a nasconderlo, rende possibile lo squarcio solo nella dimensione in cui non si ha neppure bisogno di vestirsi.
Dove gli echi non sono sirene e violenze di scontri, né esclusivamente terre di esuli, ma pure vocazioni libere di esprimersi. Il giardino di Parsipur è un fluire lecito di fantasie, volontà corrisposte, “desiderio che si fa follia” e liberazione della carne per una felicità che scavalca le fusioni criminali di culto e politica.
Si combatte un esilio reale con la coralità potente di margini aperti perché essenzialmente lirici. Le radici continuano a espandersi e il grembo condiviso vigila sui nuovi semi: la pagina di una riflessione salita al cielo con il fumo delle vite.